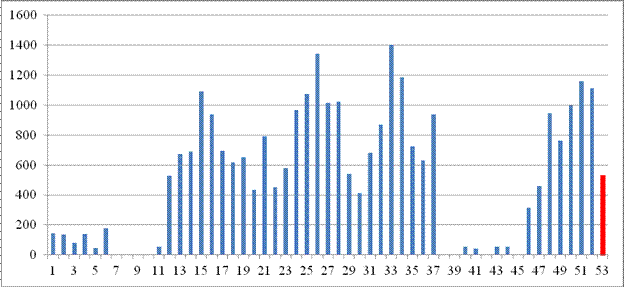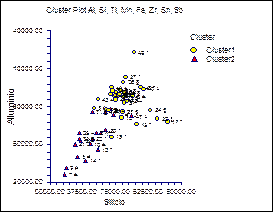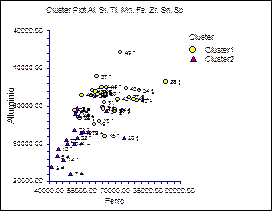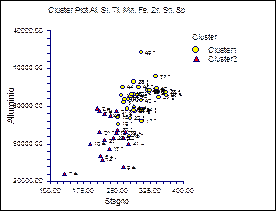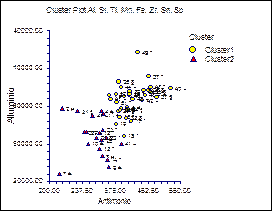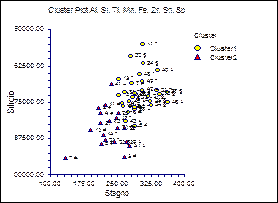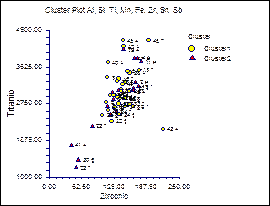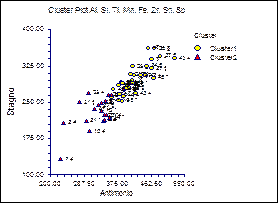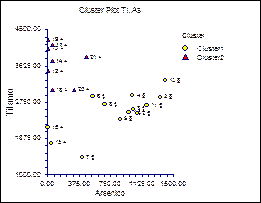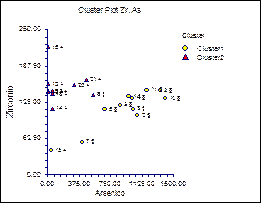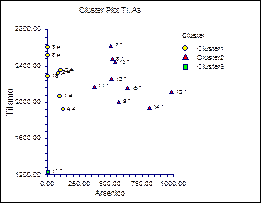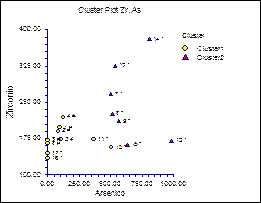|
 |
| Siti: Tesoro |
|
Le più antiche menzioni della località di Marsiliana risalgono al periodo 951-986, quando risulta che presso "Marciliana" stava accumulando terre una famiglia di livellari del vescovo di Lucca, che contribuì all’edificazione di un castello (ad oggi il tratto distintivo dell’area), avvenuta già prima del 1026.
Attorno al Castello di Marsilia si sviluppò, nei secoli centrali del medioevo, un nucleo abitativo di medie dimensioni, come attestano le concentrazioni di materiale ritrovato in sua prossimità.
Gli scarti delle ingenti lavorazioni metallurgiche effettuate negli opifici formano 4 accumuli ben distinti, ubicati in prossimità della strada per Molinpresso, ed a poca distanza dal torrente Trecina, nel punto in cui esso incontra il fiume Pecora.
Gli accumuli, delle dimensioni medie di 7x8 metri, possono essere riferiti con certezza agli impianti di fusione della Marsiliana 8Guideri 1998).
Il complesso di testimonianze archeologiche individuato nella pianura ai piedi del colle di Massa Marittima comprende, oltre agli scarti della lavorazione del rame e del piombo argentifero, tre strutture fusorie per la lavorazione dei locali solfuri misti, ed un impianto di alimentazione idraulica.
Rinvenimenti ceramici (maioliche arcaiche e ceramiche acrome depurate), possono essere legati all’esistenza di magazzini od altri tipi di strutture connesse agli impianti fusori a testimonianza, probabilmente, del fatto che all’epoca questo tipo di lavorazione avesse raggiunto una certa rilevanza per il territorio.
Da un punto di vista geologico tutti o quasi gli affioramenti del territorio della Marsiliana sono costituiti da depositi neogenici di tipo fluviale o fluvio-deltizio (conglomerati, sabbie, ghiaie e travertini). Questi sono tutti depositi legati all’attività del fiume Pecora (sintemi) che ricoprono in discordanza le formazioni dei vari domini strutturali della catena appenninica (per questi ultimi si rimanda all’inquadramento geologico generale).
Diversamente dalle zone fin qui discusse, per le quali sono notevoli le testimonianze, sia scritte sia direttamente tangibili sul territorio, di una intensa attività mineraria, nella zona di Marsiliana non è presente materiale direttamente attribuibile a materiale di discarica mineraria, così come risultano assenti (o probabilmente obliterati) gli ingressi ai pozzini esplorativi.
L’obiettivo del presente studio è stato quindi quello di verificare se la natura del materiale in zona Marsiliana, sia assimilabile a discarica mineraria o se sia caratterizzato da concentrazioni significative di elementi chimici traccianti caratteristici del materiale residuo delle lavorazioni minerarie.
Nell’area oggetto di indagini chimico fisiche XRF si alternano pinete, olivete e campi coltivati.
Il terreno è caratterizzato da granulometria molto fine e colore marrone scuro; difficilmente si nota la presenza, al suo interno, di materiale grossolano da poter anche in via ipotetica ricondurre ad eventuali pregresse lavorazioni minerarie svolte nella zona stessa o in altre limitrofe.
|
 |
 |
| Tesoro-Marsiliana. Vista dell’area oggetto di determinazione chimico fisica in situ |
Tesoro-Marsiliana. Vista dell’area oggetto di determinazione chimico fisica in situ |
Nel complesso i punti di campionamento scelti per le determinazioni analitiche sono facilmente accessibili.
Durante le campagne di misura sono state eseguite 69 determinazioni XRF in situ, scegliendo i punti di campionamento, di volta in volta, in relazione alle condizioni ritenute maggiormente significative ai fini dello studio.
Il numero di determinazioni utilizzate ai fini delle successive analisi è stato ridotto a 52 in seguito ad eliminazione dei valori anomali.
Di seguito si riporta la tabella 10 con il numero di riferimento e la relativa localizzazione delle analisi chimico fisiche in situ.
Dalle indagini chimico fisiche eseguite in situ emerge che il Piombo è presente nell’area in concentrazione piuttosto bassa, con un valore medio calcolato pari a 62 ppm, e solo in alcuni punti di campionamento ( da 7 ad 11; 26; 46) si superano i 100 ppm. In particolare sono stati rilevati tenori di Piombo rispettivamente di 107 ppm, 112 ppm, 154 ppm, 121 ppm 137 ppm nei punti di campionamento numerati da 7 a 11. Tali determinazioni (Tabella 10) sono state effettuate su materiale di pezzatura fine e colore scuro, rinvenuto all’interno di una pineta adiacente ad un vigneto; tuttavia le concentrazioni degli elementi chimici Ag, Cu, Zn, As qui rinvenute, sono piuttosto basse (addirittura inferiori al valore medio del limite di rilevabilità strumentale LOD per Ag ed As) con un valore medio per Cu e Zn pari rispettivamente a 61 ppm e 157 ppm.
La misura numero 26, caratterizzata da un tenore di Piombo pari a 101 ppm, è stata eseguita su una porzione all’interno di un campo coltivato a granturco, caratterizzato da terreno a granulometria piuttosto fine e colore marrone scuro. In questo punto si sono inoltre riscontrate 108 ppm di Cu, 203 ppm di Zn ed una concentrazione notevole di As (1344 ppm).
Il piombo è presente, infine, in concentrazione pari a 170 ppm, all’interno di un campo coltivato (ancora a granturco) dove il materiale è a granulometria piuttosto grossolana e caratterizzato da colore variabile; qui l’Argento e l’Arsenico risultano inferiori al valor medio dell’intervallo di rilevabilità strumentale, mentre sono presenti 103 ppm di Cu e 270 ppm di Zn.
I punti di campionamento da 38 a 47 (Tabella 10) sono stati scelti in corrispondenza di un’area caratterizzata dalla presenza piuttosto massiccia di materiale di pezzatura grossolana e colore variabile, a predominanza rossastra, nel quale erano stati ritrovati residui dall’aspetto assimilabile a scorie di arrostimento, di colore verde o grigio scuro.
In corrispondenza di tali punti di campionamento tuttavia, le concentrazioni dei metalli Pb, Zn, Cu, risultano del tutto confrontabili a quelle globalmente determinate per l’area.
I valori medi (ppm) di Pb, Cu, rilevate nella zona della “ipotetica discarica” risultano infatti rispettivamente pari a: 61 ppm (contro i 60 ppm di media complessiva), 73.1 ppm (contro i 61 ppm di media complessiva). Il metalloide As, invece, raggiunge nell’area i picchi di concentrazione di 313 ppm e 458 ppm.
Le indagini svolte hanno rilevato che, complessivamente, il tenore di As nell’area risulta piuttosto elevato, con un valore medio calcolato pari a 533 ppm.
Valori eccezionalmente alti del metalloide (dell’ordine dei 1000 ppm) sono state rilevate all’interno del perimetro di un campo coltivato a granturco, caratterizzato da granulometria piuttosto fine e colore marrone scuro.
Di seguito si riporta l’istogramma relativo all’andamento della concentrazione di As per l’area complessivamente sottoposta ad analisi: la barra in rosso rappresenta il valore medio di [As] (ppm) calcolato. |
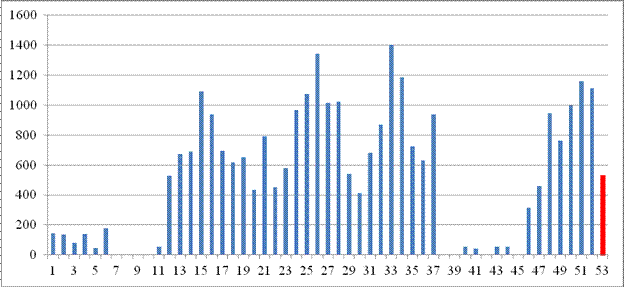 |
| Istogramma relativo all’andamento della concentrazione del metalloide Arsenico in funzione del punto di campionamento. In rosso si riporta, per confronto, la barra rappresentante il valore medio determinato per l’area nel suo complesso |
Il grafico evidenzia come la [As] sia elevata in corrispondenza delle zone di campionamento identificate dai numeri di riferimento da 12 a 37 e da 46 a 52.
La prima serie di numeri di riferimento corrisponde ad aree di campionamento varie ma tutte, comunque, caratterizzate da materiale di pezzatura fine e colore marrone scuro. All’interno di tale intervallo ricade anche l’area di campionamento del sopra citato campo coltivato a granturco.
Le determinazioni analitiche da 46 a 52, invece, sono state effettuate all’interno del perimetro di un campo coltivato che si estende sotto all’accumulo di materiale di pezzatura e colore variabili per il quale era stata ipotizzata una eventuale natura di discarica mineraria. Il terreno presente nel campo in questione è, in effetti, ancora piuttosto grossolano e non finemente suddiviso come invece nelle altre aree oggetto di analisi, cosa che farebbe in via del tutto teorica ipotizzare che si tratti di un prolungamento dell’eventuale accumulo di materiale di discarica.
La pezzatura del materiale rappresenta uno dei fattori di interesse primario ai fini della discussione di una possibile mobilitazione del metalloide: è infatti noto come la frazione tessiturale più piccola (argillosa, < 2 micrometri) sia in grado di contenere maggiori quantità di As adsorbite (Lombi et al., 2000), poiché in essa sono tipicamente concentrati ossidi e idrossidi (di Alluminio, Manganese e specialmente Ferro) (Inskeep et al., 2002) che di solito presentano dimensioni estremamente ridotte. Questo spiega la più alta tossicità di questo tipo di suoli rispetto a quelli a tessitura grossolana (Jacobs et al., 1970). Anche la sostanza organica gioca un ruolo importante nel determinare la mobilità del metalloide. Thanabalasingam e Pickering (1986) studiando l’adsorbimento di As(III) e As(V) su acidi umici, hanno dimostrato come questo sia influenzato dal pH e dalla concentrazione dell’elemento.
Il terreno oggetto delle misure in situ dalla 12 alla 37, oltre ad elevati tenori di As, mostra anche le caratteristiche chimico-fisiche adatte allo “stoccaggio” di una maggiore quantità del metalloide in quanto caratterizzato da pezzatura piuttosto fine e da elevati tenori degli elementi Al, Mn, Fe presenti rispettivamente in concentrazione media di: 69088 ppm, 2401.36 ppm e 60578.8 ppm. Inoltre, il colore marrone scuro (mantenuto nel terreno anche in periodo lontano da eventi piovosi quale quello in cui sono state effettuate le indagini chimico fisiche) lascia ipotizzare un contenuto di sostanza organica piuttosto elevato.
Diversamente dal caso precedente, il terreno oggetto delle analisi dalla 46 alla 52 è caratterizzato da pezzatura grossolana; tuttavia le concentrazioni medie di Al, Mn ed Fe risultano pari rispettivamente a 91542.86 ppm, 3414.143 ppm e 62713.57 ppm, valori addirittura superiori rispetto alle medie ricavate per le misure dalla 12 alla 37 e superiori alla media calcolata per la concentrazione dei tre metalli per l’area globalmente in esame ( 73237 ppm di Al, 2700 ppm di Mn e 60218 di Fe). Quindi, pur essendo le caratteristiche fisiche del suolo non favorevoli allo stoccaggio di As, l’elevato tenore di Alluminio, Ferro e Manganese potrebbe comunque favorire il mantenimento di una elevata quantità del metalloide nel suolo.
Da tenere presente che tali considerazioni sono da considerarsi del tutto ipotetiche in quanto la tecnica analitica utilizzata non permette di ricavare informazioni circa la speciazione degli elementi chimici ma fornisca esclusivamente il dato analitico in termini di concentrazione complessiva nella matrice analizzata. Considerando tuttavia le concentrazioni molto elevate di Alluminio, Manganese e Ferro, è possibile ipotizzare in via approssimativa che una parte non trascurabile di questi sia presente nel terreno sottoforma di ossidi e/o idrossidi, data anche la natura del materiale rock forming. Inutile sottolineare che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in merito alla situazione descritta per delineare gli eventuali processi di mobilitazione del metalloide.
L’analisi statistica di suddivisione in gruppi è stata eseguita inizialmente fornendo in input al software tutte le 52 misure ed un numero di cluster fissato pari a 2. Le serie di concentrazione analitiche (ppm) degli elementi (considerati come traccianti del fondo naturale) sottoposte a clustering sono: Al, Si, Ti, Mn, Fe, Zr, Sn, Sb. Di seguito (figura 66) si riportano alcuni dei diagrammi binari ottenuti e ritenuti di più facile comprensione. |
| Cluster Plots ottenuti mediante K-Means Clustering Analysis sugli elementi Al, Si, P, S, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Zr, Sn, Sb, Pb. a) Al-Si; b) Al-Fe; c) Al-Sn; d) Al-Sb; e) Si-Sn; f) Ti-Zr; g) Sn-Sb |
In tutti i diagrammi binari si osserva una buona correlazione fra la concentrazione dell’elemento riportato in ordinata e quello riportato in ascissa. Tali fenomeni sono riconducibili alla composizione chimica del materiale caratteristico delle formazioni in posto e, come è evidente dai grafici, sono comuni a tutti i punti di campionamento.
L’analisi clustering successiva, invece, è stata eseguita considerando le seri analitiche di concentrazioni ottenute nei due campi ad elevato tenore di As e precisamente il campo coltivato di cui alle determinazioni analitiche dalla 12 alla 37 ed il campo coltivato sotto al cumulo di materiale di pezzatura grossolana costituente l’ipotetica discarica mineraria.
Di seguito si riportano i grafici binari di correlazione fra la concentrazione del metalloide As e le concentrazioni degli elementi immobili Ti e Zr. |
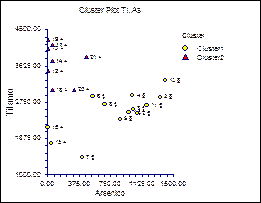 |
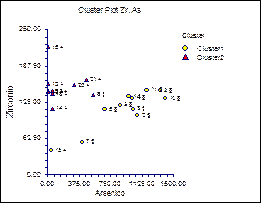 |
A |
B |
Cluter Plots ottenuti mediante K-Means Clustering Analysis sugli elementi As, Ti, Zr. a) Ti-As; b) Zr-As
|
Dai grafici è possibile osservare come i punti contrassegnati da § (campo coltivato a granturco con materiale di pezzatura fine) siano interamente nel cluster giallo mentre quelli contrassegnati da + (campo coltivato con materiale di pezzatura grossolana) siano nel cluster rosso.
La netta suddivisione dei dati relativi alle due arre lascia ipotizzare una diversa origine dell’elevata concentrazione del metalloide per determinare la quale sarebbero necessari ulteriori approfondimenti.
Discussione dei risultati ottenuti mediante analisi chimico-fisiche in laboratorio
Le indagini chimico-fisiche eseguite presso il Dipartimento Farmaco Chimico tecnologico dell’Università degli studi di Siena sui campioni, prelevati ad intervalli regolari, e trattati come da protocollo operativo EPA 6200, confermano elevati tenori di As in tutta l’area in esame, con particolare riferimento ai due campi coltivati di cui sopra.
L’analisi di suddivisione mediante il metodo K-Means è stata eseguita sulle concentrazioni del metalloide As e degli elementi immobili Zr e Ti. I migliori risultati di visualizzazione si sono ottenuti con un numero di clusters pari a tre (correlazione Ti-As) e con un numero di clusters pari a due (correlazione Zr-As). |
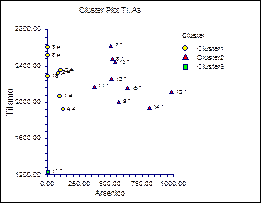 |
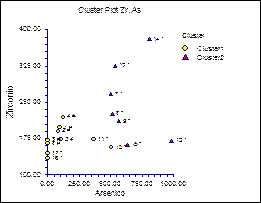 |
Cluster Plots ottenuti mediante K-Means Clustering Analysis sugli elementi As, Ti, Zr. a) Ti-As; b) Zr-As
|
|
|
|